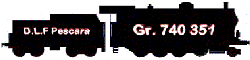
Pescaraferr

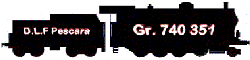 |
Pescaraferr |
 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
Uso degli attrezzi
per fermodellismo -VIII |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alesatori A completamento di quanto detto l'ultima volta, osserviamo che i fori eseguiti con punte da trapano ben raramente rispondono alla precisione richiesta da accoppiamenti del tipo di quelli ivi descritti. Sul diametro del foro influisce, infatti, oltre allo stato di affila tura della punta, la precisione del mezzo impiegato per la foratura. Usando un trapano a mano, ad esempio, è facile -per non dire certo- che la punta si presenti leggermente obliqua, con le conseguenze che è superfluo illustrare. Quando si vogliano ottenere fori molto precisi, si ricorre all'alesatura operazione successiva e complementare alla foratura, e non sostitutiva -che apporta ai fori le necessarie correzioni di dimensioni e di assialità, rendendone anche più levigata la superficie interna. L'attrezzo idoneo a questa operazione è l'alesatore, che può essere azionato a mano o a macchina. Gli alesatori per fori cilindrici lavorano come le punte da trapano, cioè con moto rotatorio associato a moto di traslazione secondo l'asse del foro. L'aspetto esteriore di un alesatore non pare, ad un profano, molto diverso da quello di una punta elicoidale da trapano, ma non inganna certo chi ha un minimo di pratica. Un alesatore è costituito da una barretta cilindrica di acciaio speciale temperato, dotata per un buon tratto della sua lunghezza di scanalature longitudinali munite di tagliente, cioè di spigolo a scalpello atto a staccare piccoli trucioli. Talvolta le scanalature sono lievemente elicoidali, più spesso diritte. L'estremità della parte scanalata è conica, in modo da consentire un imbocco corretto. Come già accennato, infatti, l'alesatura va preceduta dalla foratura, da eseguire con diametro di qualche decimo di mm minore del finito. Ad esempio, volendo alesare a Ø 3, si prefora con punta elicoidale e5 2,75 e poi si passa l'alesatore. Il gambo dell'alesatore, che si estende per meno di metà lunghezza, ha diametro di 0,1 -:- 0,2 mm minore del diametro nominale e termina con un codolo quadrato, al quale si applica il "giramaschi", sorta di leva a due braccia con morsetto centrale che prende il codolo quadro. Afferrato il giramaschi all'estremità dei bracci, si introduce nel foro l'estremità conica dell'alesatore di quel tanto che basti a garantire una buona guida durante il lavoro, e si imprime all'utensile un moto lento di rotazione, esercitando nel contempo una certa pressione in senso assiale per ottenerne la traslazione. Se il foro è passante, l'alesatore dovrà attraversarlo per intero ed uscire dalla parte opposta all'entrata. Se il foro è cieco... beh, lasciamo perdere! Neppure è il caso di parlare dell'alesatura a macchina, dati i mezzi inadeguati a disposizione. Diciamo, invece, che è difficile trovare in commercio alesatori per diametri inferiori a 3 mm, quali sarebbero i più utili per i modellisti. Bisogna dunque imparare... ad arrangiarsi altrimenti, soprattutto usando punte da trapano correttamente affilate. La tornitura interna -argomento trattato nel Cap IV - è una vera e propria alesatura: se ne possono ottenere risultati assai soddisfacenti, ma su fori... non inferiori a Ø 3, a meno che non si sappia fabbricare un utensile apposito, di forma corrispondente a quella illustrata nella fig. 13, che possa passare anche entro fori più stretti. Ma non è roba da principianti! Viti e madreviti Il modellista esigente sa quale pena costi la ricerca delle viti occorrenti per una determinata applicazione. A parte le seccature che si infliggono agli altri, le viti eventualmente reperite sono., o troppo grosse, o troppo piccole., o troppo lunghe, o troppo corte, o con testa inadatta, e via dicendo. C'è da impazzire! Donde l'opportunità di acquistare la indipendenza anche in questo campo. E' un lavoro non difficile, a parte la necessità di procurarsi una certa attrezzatura, che ora descriveremo. Precisiamo che l'operazione prende il nome di filettatura. Con essa si genera il filetto di una vite o di una madrevite: la filettatura intorno a un gambo genera una vite, quella sulla parete interna di un foro una madrevite. La prima si ottiene con un utensile detto filiera, la seconda mediante maschi. L'elemento essenziale di una filettatura è il passo, cioiè la distanza, misurata assialmente., tra un filetto e il successivo: corrisponde all'avanzamento della vite (avanti o indietro) per ogni giro. Altri elementi importanti sono: il diametro esterno o nominale (si usa per la designazione), il diametro interno o di nocciolo (misurato sul fondo dei solchi fra i filetti) e il diametro medio, che viene misurato a metà altezza dei filetti ed è praticamente la media fra i diametri esterno ed interno. Importante è pure il profilo, cioè la forma della sezione trasversale del filetto. Nelle viti usuali di interesse modellistico il profilo è triangolare; molto usato per viti importanti è il profilo trapezio. Perchè una vite ed una madrevite possano andare d'accol1do, devono avere diametri corrispondenti e il medesimo passo. Le filettature di maggiore interesse per noi riguardano le viti più piccole, diciamo fino a Ø 3, appartenenti al sistema cosiddetto metrico (tralasciamo il sistema inglese Whitworth). Esse sono unificate: stralciamone le caratteristiche dalle tabelle:
Una filettatura si designa brevemente col
diametro esterno e il passo. M 2 x 0,4 in cui M indica il sistema
(metrico, nel nostro caso; W indicherebbe il sistema Whitworth),
Innestato nel giramaschi il
maschio sbozzatore (porta in genere una riga sotto il codolo), se ne
introduce |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|